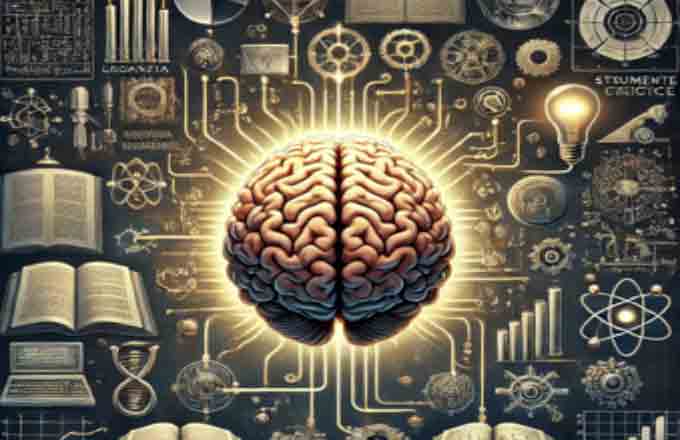Arrivate in Sicilia per liberare l’isola dal sottosviluppo, le partecipazioni statali finirono con l’alimentare l’industria del malaffare con il loro management prevalentemente padano.
Non avevano pianificato la malandrineria, non era nel loro profilo genetico, nelle loro corde né nelle loro intenzioni, ma accadde, perché subirono l’ambiente e lo tollerarono fino ad accettarlo come il male con cui convivere, una necessità ineludibile. Il prezzo da pagare, insomma.
Questo non assolve l’industria, naturalmente, la rende piuttosto partecipe degli eventi, le fa assumere una parte di responsabilità (di non lieve entità). Più che un tradimento ed un comparaggio con il malaffare, è stata forse l’ansia del quieto vivere, il bisogno di pace sociale all’interno della fabbrica e di relazioni amicali con i potentati del territorio: politici, istituzionali e paramafiosi.
Le partecipazioni, insomma, ampliarono la già vasta zona grigia, che alimenta, sostiene, fa crescere la limacciosa palude del malaffare e della politica di scambio, paramafiosa e non. L’equazione povertà=crimine - benessere= probità sociale e legalità si rivelò falsa quanto quella, altrettanto celebre degli effetti moltiplicativi che l’industria di base avrebbe stimolato.
Più che l’insipienza, il cinismo, il comparaggio farei salire sul banco degli imputati il credito che nelle grandi sfere godevano le partecipazioni statali, la convinzione che il “pubblico” avesse a cuore le buone pratiche.
Invece che lo spirito del buon samaritano, la mano pubblica doveva piuttosto misurarsi con il mercato e con i poteri forti del Paese, che non volevano lasciarsi rubare la leadership nel triangolo industriale e i sontuosi incentivi alla “locomotiva” nazionale, spina dorsale dell’Italia post-bellica.
Il contesto era articolato, la zona grigia costituiva un arcipelago di realtà diverse fra loro, ma tutte accomunate dall’illegalità diffusa, la microcriminalità, la grande razzia del territorio, perpetrata attraverso la speculazione fondiaria, che ha dato origine alle bidonville che si arrampicano sulla collina, precipuamente sul lato piana.
I grandi partiti, Dc e Pci, chiudevano gli occhi e, addirittura, talvolta, alla ricerca del consenso, sposavano la causa dell’abuso e dell’illegalità sull’altare del diritto (della povera gente) di campare e farsi una casa. Solidarismo (democristiano) e appartenenza sociale comunista (di classe e non) dettarono legge e sanatorie.
Ad assolvere l’illegalità contribuì in modo determinante l’assenza di strumenti urbanistici (per l’abuso edilizio), ed il bisogno di posti di lavoro, la necessità di uscire, a qualunque costo, dal celebre circolo vizioso depressivo, piattaforma sociologica utile a forzare la mano agli scettici per imprimere una svolta al meridionalismo, fino ad allora cartaceo e teorico. Si crearono le condizioni ideali perché si tradissero i presupposti dell’intervento più significativo, in termini di risorse pubbliche, dello Stato nel Mezzogiorno d’Italia, il petrolchimico di Gela, trainato dalla scoperta del petrolio.
Non è tutto, naturalmente. La chimica di base aveva, ed ha ancora, una propensione ad avvelenare il territorio ben nota agli esperti (ma ignota o nebulosa ai destinatari delle pozioni velenose): l’inquinamento – marino, atmosferico, alimentare…,malattie cancerogene, malformazioni nelle nascite, ambiente malsano, devastazione delle coste ecc.
La storia di Gela è esemplare. Era una comunità litigiosa, ma non ospitava racket né crimini di mafia. Un paesone vivace ma lontano dal Vallone e dalla lupara riesina. Fino all’inizio degli anni Settanta, i boss – arrivati a frotte e tutelati dalla politica nissena – si ritagliavano in pace, comunque senza spargimento di sangue, le loro aree di competenza lungo il fiume di denaro che affluiva a Gela dall’Eni e dalla Cassa per il Mezzogiorno. Fino a che Cosa nostra impose obbedienza e la Stidda pretese di fare da sé, prendendosi il controllo del traffico gommato (il capo dei padroncini era anche il capo della Stidda).
Non ne sapevano niente i dirigenti dell’industria di Stato?
Gela di buon animo assecondò il suo destino, uguale a quello delle aree del sud chiamate a ospitare l’industria. Depositaria di virtù taumaturgiche, che gli esperti definivano effetti moltiplicativi, la fabbrica conquistò anche le migliori coscienze. Quando le trivelle dell’Agip toccavano lo strato di greggio, la gente aveva la sensazione che nelle tasche stessero per depositarsi banconote di grosso taglio. Ma non era così, credevano nelle favole.
Gli effetti moltiplicativi ci furono, solo che non riguardarono le nuove fabbriche, ma le bande criminali: le mafie trasformarono la città in un inferno, fu l’americanizzazione dell’“onorata società” (bande di gangster con regole antiche). Lo Stato non c’era e se c’era dormiva.
La popolazione e i bisogni si triplicarono in pochi anni, ma tutto rimase come prima: stessa quantità di acqua nei rubinetti, di aule scolastiche, letti d’ospedale, medici, poliziotti. I magistrati non c’erano prima e continuarono a non esserci. L’aria sapeva di zolfo, avvelenava gli alberi, appestava gli animali e la gente, i pesci morivano o scappavano dal loro mare insieme con le lampare.
L’industria desolava la città ma nessuno capiva niente di quello che effettivamente stata succedendo. Tutti erano d’accordo che succedesse quel che succedeva, perché finalmente arrivava il lavoro e gli strumenti di produzione erano in mano allo Stato e non in mano ai padroni. Occhi bendati (e occhi spalancati) non videro il dominio mafioso sull’appalto pubblico delle grandi opere e sull’appalto pubblico-privato distribuito dai grand commis di Stato, che da Milano e Roma dirigevano il traffico senza rischiare le pallottole.
In Sicilia, come in Campania e in Calabria, clientele politico-mafiose, manager del Nord, cecità ideologiche hanno partecipato al disastro meridionale, e continuano a farlo. Siccome da questo disastro hanno tratto utili in tanti, è legittimo nutrire dubbi sulla loro santità.
Tutto questo è stato chiamato progresso. Non lo era, era ben altro. Un “ben altro” che non poteva essere bandito né processato. La comunità era caduta in una trappola mortale, dalla quale sarebbe stato impossibile perfino pensare di liberarsi. Come rinunciare a quasi diecimila posti di lavoro, senza alcuna alternativa? Come pretendere dal sindacato, e dalle forze politiche e sociali, un’azione di contrasto ai veleni ed alla limacciosa palude dell’indotto e dell’edilizia illegale, garanzia ineludibile per mantenere un reddito ed una condizione sociale finalmente dignitose?
Per la prima volta, e l’evento merita grande considerazione, la scuola ha raccontato ciò che è avvenuto con un documentario che sta facendo il giro d’Italia, promosso dall’Università di Catania e dal Liceo scientifico Vittorini di Gela. Piuttosto che studiarla attraverso libri (che non fanno parte dei programmi scolastici), i giovani del “Vittorini”, aiutati da prof diligenti, e guidati dalla dirigente, Angela Tuccio, l’hanno fatta attraverso testimonianze e immagini di grande impatto.
Non so fino a che punto i giovani siano stati i protagonisti di questa produzione e quale sia stata la parte recitata dai prof e dall’istituzione scolastica. Deve prevalere la fiducia e la gratitudine su questa “primazia”, sul lavoro generoso dei ragazzi, l’entusiasmo dei docenti, la buona volontà e, in qualche caso, la illuminata coscienza dei testimoni che nel documentario – titolato “Sconvolgimenti” – hanno raccontato se stessi e la città.
Certo gli “Sconvolgimenti” non sono stati narrati con accenti… sconvolgenti. Non hanno trovato posto il crimine organizzato, il fenomeno dell’illegalità, l’abuso diffuso, i tradimenti della fabbrica e il suo desolante tramonto, la città com’è oggi, una finestra sul futuro, ma c’è quel che serve per consegnare alle nuove generazioni, pagine, seppur sbiadite, di storie finora raccontate con molte gravi omissioni e pregiudizi.
I liceali del Vittorini hanno aperto la strada, possono vantare un credito e va reso loro merito. Se hanno dovuto mettere in moto una macchina, tirando spesso il freno a mano, non mi sento di addebitarglielo. Né a loro, né ai prof. Quindi, un plauso.