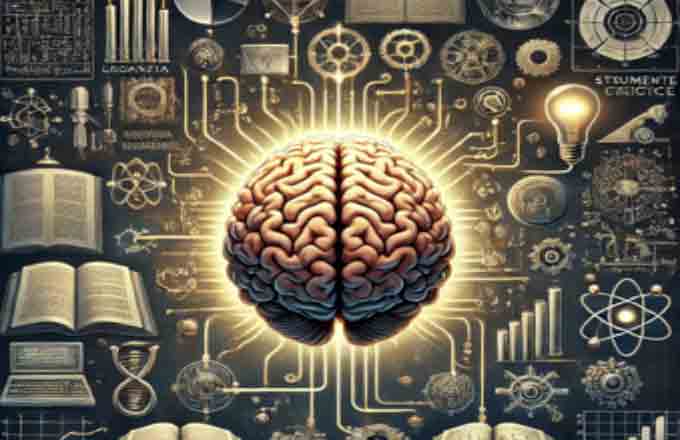L’Eni ha annunciato l’ammaina bandiera: le ciminiere e la centrale a carbone, simbolo del petrolchimico di Gela saranno presto smantellati. (Ne ha già parlato dettagliatamente Franco Infurna nel numero scorso).
L’epopea del petrolio finisce. Mezzo secolo intenso, ricco di eventi straordinari, che hanno cambiato tutto, la città ed i suoi abitanti, e che hanno scritto le pagine più importanti della storia del Meridione d’Italia. Ogni ammaina bandiera immalinconisce, ma a nessuno verrà il magone per la demolizione delle ciminiere, né verrà in mente di danzare in piazza e sparare fuochi d’artificio per festeggiare la fine di un incubo. Perché le ciminiere sono i fantasmi di un incubo; un incubo di quelli che fanno sobbalzare di notte e non permettono di chiudere occhio. Sentimenti contrastanti, dunque. Eppure assolutamente comprensibili.
Quando è cominciata l’avventura, con i pozzi di petrolio sulla piana e nel golfo, e le ruspe spianavano le colline di sabbia al di là del fiume ed ai piedi della collina, per costruire il gigante della chimica, è stato come piantare una bandiera su Marte, come consegnare al futuro un bene prezioso. Un bene misterioso, seducente, intrigante, possessivo. Questo fu il tempo dei pionieri, delle avanguardie operaie, dei nuovi mestieri e delle nuove professioni. Chi cambia mestiere, indossata la tuta se la porta addosso, immacolata, anche durante le passeggiate serali sul Corso. E’ una divisa, un segno di nobiltà: il posto sicuro, l’élite operaia, una vita senza affanni, la casa di proprietà, le vacanze, i figli ben vestiti e istruiti.
E’ caduto il muro della separatezza: il tenore di vita della comunità operaia non ha nulla da invidiare a quello della borghesia delle professioni. I prof acculturati leggono distrattamente i giornali o non li leggono affatto, mentre gli operai li divorano e ne imparano a memoria gli articoli intriganti, sanno parlare e scrivere meglio degli “intellettuali”. Capiscono meglio di loro ciò che sta avvenendo, si organizzano con un sindacato forte, che ha imparato ciò che serve in poco tempo. Un autentico miracolo. Una rivoluzione culturale che contagia anche quelli che non lavorano sotto le ciminiere e percepiscono gli umori grevi dell’aria che sa di cloro e naftalina. Cade il muro della separatezza e ne nasce un altro, che lascia fuori chi non vive della fabbrica.
Il potere della fabbrica cresce insieme alle isole del petrolchimico di giorno in giorno fino a pretendere genuflessione della municipalità. O meglio, la consuetudine all’inciucio. Tu mi dai una cosa a me ed io ti do una cosa a te. Bisogna farci i conti con la fabbrica; è la fabbrica che detta i tempi, le mode, i commerci. Instaura una dipendenza totale.
La generazione del petrolio ha il cuore nella città e la testa in contrada Maroglio, dove sorge il petrolchimico: la fabbrica s’è presa tutto – il bosco, il lago, il mare, gli alberi – senza rubare niente. La luna di miele dura quasi un lustro, fino a che la chimica domina il mercato, e il gigante cresce, trascinando l’indotto. Poi il matrimonio di convenienza comincia a suscitare passioni tristi, qualcuno si sveglia dal torpore provocato dal benessere, e i cattivi odori che le ciminiere sprigionano, divengono insopportabili. Appena gira il vento, la città sente il sapore amaro dei “fumi”. Per quanto alte, le ciminiere non cancellano gli umori grevi.
Un altro lustro, e poi, pezzo dopo pezzo, l’Eni fa i bagagli. Allora la città torna a stringersi attorno alla fabbrica, i miasmi subiscono una violenta derubricazione. Sì, è vero, si muore di inquinamento, nel mare si nuota fra chiazze di petrolio, gli alberi “arrugginiscono”, i figli nascono sbagliati, ma senza il lavoro non c’è vita né dignità. Gela diventa ostaggio dell’industria, più di prima e peggio di prima. C’è il mutuo da pagare, i figli da mandare all’università, il tenore di vita da mantenere. E soprattutto l’orizzonte è nero.
Gela ha una piana sterminata, assolata e ventosa. Un sito ideale per l’energia alternativa, eolica e solare. Il green conquista il centro della scena, ma l’Eni si gioca le carte altrove, nel Mediterraneo egiziano, nella poverissima Nigeria, ovunque ci sia da rimettere a sesto i bilanci. Gela non conta più niente, né sul piano politico né sul piano economico: il meridionalismo è messo in soffitta, la Cassa per il Mezzogiorno è simbolo di spreco e malaffare, la questione da affrontare è quella settentrionale. Certo ci sarebbero le imprese gelesi, siciliane, nazionali, che potrebbero investire sul sole ed il vento, l’energia green e il mercato del lavoro dotato di know how, ma nessuno si fida della municipalità.
L’investimento deve prevedere una quota da spalmare con equità ai decisori occulti, come si faceva un secolo prima o due secoli prima, quando c’era da soddisfare il palato dei borboni, dei piemontesi, dei briganti, delle mafie, prima di aprire il negozio. Ovviamente non se la sente nessuno di rischiare sulla palude invisibile. Perciò l’orizzonte non fa vedere alternative, e l’ammaina bandiera suscita sentimenti ambigui, contraddittori, perciò è impossibile far festa sull’altare della buona salute, tirare un sospiro di sollievo. E’ vero, magari si respira a pieni polmoni si può fare il bagno a mare senza insozzarsi di catrame, ma bisogna preparare i bagagli per andare dove c’è da lavorare. Nel Nord o all’Estero.
Ogni ritirata spaventa e suscita rabbia, scontento, amarezza, ma regala tuttavia uno spiraglio a pensieri di speranza e nuovi propositi. Ora si tratta di allargare lo spiraglio, mettere a reddito ciò che si è imparato per più di due lustri stando a fianco del padre padrone, il gigante dell’industria ormai in fuga.
La domanda ce la dobbiamo fare comunque: è una sconfitta che ci si prepara a vivere con la demolizione di quel che resta del petrolchimico, o una vittoria del buonsenso? L’una e l’altra, purtroppo. E’ andata sempre così ovunque, quando si ammaina bandiera. Gela vive la sua Hanoi, deve viverla con dignità, almeno. La disfatta dei soldati americani che ad Hanoi lasciarono in fretta e furia il Paese dopo avere perso sul campo cinquantamila vittime, se ne andarono con il cuore contento, mentre i vietnamiti, moralmente vittoriosi, erano spaventati dal futuro incerto con una nazione in rovina.
Lo scoramento di Gela è giustificato quanto il sollievo procurato dal cielo liberato dai fumi. Chi si è battuto per il diritto alla salute, la vivrà come una vittoria; chi si è battuto per il lavoro come una sconfitta; ma per chi si guarda attorno, incredulo, e allunga lo sguardo fuori dai confini della città, è una vittoriosa sconfitta, rimpiangerà le ciminiere che ha odiato con tutta l’anima.
Il mezzo secolo della Gela industriale, tuttavia, non può passare come un libro di storia che abbiamo finito di leggere. Gela resta uno dei primi tentativi di trasferire il secolare dibattito (cartaceo) sul meridionalismo in una concreta presenza dello Stato nel Mezzogiorno d’Italia. L’abbandono di Gela da parte delle Partecipazioni Statali ci restituisce la testimonianza di un fallimento, che pretende un “risarcimento” alla comunità che ha fatto da “cavia” all’esperimento di sviluppo sbagliato.
Si dovrà pur ragionare sul processo d’industrializzazione, sull’investimento dello Stato nell’industria primaria e la sua assenza nei servizi e nelle infrastrutture. La comunità è stata abbandonata al suo destino di solitudine, non si costruiscono cattedrali nel deserto. E’ questa la lezione che viene da Gela. Ora non serve battersi il petto, serve far tesoro dell’esperienza fatta e riprendere il cammino.