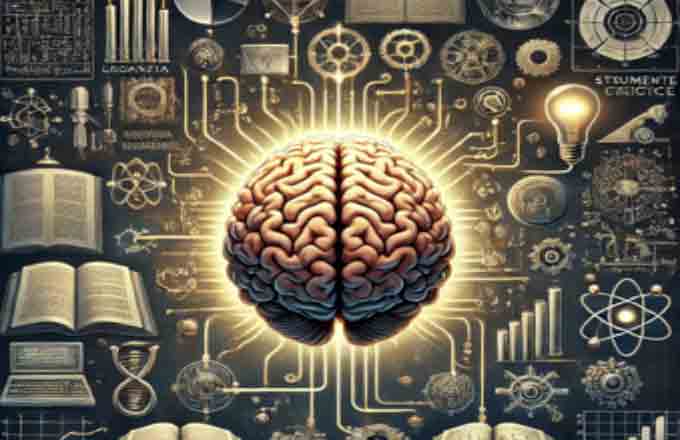“E’ con le migliori intenzioni che si producono gli effetti peggiori”.
Ricordo la massima di Oscar Wilde perché regala alla storia recente di Gela la morale che non vorremmo apprendere. Il mio approccio pragmatico applicato al business coaching, su Gela, induce a cercare solidi appigli alle buone intenzioni. Occorre una buona dose di fede negli uomini e nelle istituzioni.
L’area industriale del Mezzogiorno negli anni sessanta rappresentò la testimonianza concreta ed inoppugnabile di una svolta. Niente più relazioni, co nvegni e dibattiti sul sottosviluppo del Sud, ma investimenti pubblici, una montagna di soldi. Ma non sarebbe passato molto tempo che le risorse generosamente profuse dal governo centrale e dal Ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno deludessero e fossero giudicati un investimento non produttivo di sviluppo, e la grande fabbrica di Gela, appena realizzata, divenisse la “cattedrale nel deserto”.
Gli autori del processo rivoluzionario non cambiarono il volto del Paese, regalandogli la vera unità (non solo sangue, storia e lingua, ma anche un benessere comune): né figli e figliastri ma una grande nazione e un grande popolo legato da interessi i comuni, da difendere e sviluppare. Le migliori intenzioni, insomma.
Ho seguito da testimone oculare la prima fase del processo, da gelese e da giornalista, ed ho potuto perciò valutare, da spettatore interessato, gli elementi peculiari del cambiamento.
La complessità dell’esperimento di industrializzazione indotta ha reso dapprima difficilmente riconoscibili i mutamenti sperimentati in corpore vili dagli apprendisti stregoni imprestati dalla politica e dall’economia. E’ avvenuto in pochi anni a Gela ciò che altrove ha richiesto secoli, e i nodi al pettine sono arrivati abbastanza presto. L’inquinamento dell’aria e del mare, la devastazione delle coste, l’avvelenamento delle falde acquifere e della campagna, l’abbruttimento del paesaggio – in una parola il degrado ambientale – sono stati subito sotto gli occhi di tutti, non solo degli addetti ai lavori. Sarebbe miope assolvere le comunità locali da ogni responsabilità a causa della assenza di competenze.
E’ indubbio, tuttavia, che il velo di nebbia che ha impedito di vedere le cose come stanno da subito sia dovuto ad una straordinaria crescita di posti di lavoro nel territorio, al maggiore benessere determinato dalla crescita del reddito, e dalla assenza di parametri “futuri” capaci di misurare l’encontable: ciò che non può essere calcolato aprendo il portafogli. In definitiva dobbiamo addebitare a noi stessi un concorso di colpa in percentuale non irrilevante.
Si diviene ciechi quando non si prevedono gli effetti di ciò che facciamo e facciamo valutazioni legate alla contingenza, senza prendere in alcuna considerazione le conseguenze negative.
Non è stato, comunque, il destino ad accecarci, siamo stati noi stessi a indossare una benda agli occhi per non vedere che una parte dell’orizzonte, quello che non ci piaceva vedere.
Cercando di seguire passo passo le pagine della nostra storia più recente, dobbiamo collocare sul posto d’onore gli anni settanta, quando si completa la realizzazione dei gigante dai piedi d’argilla.
Con le “isole” della grande fabbrica ormai al completo, raggiunta la vetta, gli scalatori con i loro sherpa hanno potuto avere dal picco più alto la vista lunga e confrontarsi con la realtà: l’obsolescenza degli impianti, la volubilità del mercato e dei prodotto di base della chimica, la concorrenza (sleale) dei paesi in via di sviluppo sui costi della manodopera, le nuove sensibilità ambientali, e soprattutto, il consolidarsi di una rete di mafie locali e non, aggrappate come sanguisughe agli appalti pubblici ed alle commesse private (nell’indotto).
Questa consapevolezza del management e della comunità è maturata nel momento di massima espansione della fabbrica, sempre più sola nel territorio, e costretta a subire il peso dell’assenza di alternative, occupazionali ed imprenditoriali. La fede inossidabile sugli effetti moltiplicativi, predicata per molti anni, è però scomparsa. Le fabbriche di plastica nate a ridosso dello stabilimento petrolchimico comprano la materia prima in Ungheria, dove i costi della materia prima sono più bassi, chiudono battenti. E fallisce anche quell’impresa pionieristica del “barile” di petrolio sorta a ridosso della piccola raffineria, ubicata a fine anni cinquanta nel porti rifugio.
L’occupazione tocca comunque il suo picco negli anni settanta. Sono 5500 i dipendenti diretti dell’Eni, tremila i lavoratori nelle imprese dell’indotto. Cifre approssimate per difetto. Accanto all’indotto “diretto” al servizio della fabbrica, andrebbe calcolato anche un indotto indiretto, nel terziario e nei servizi, di cui non si hanno i numeri.
Nel 1990 i 5500 dipendenti divengono tremila, i tremila dell’indotto si dimezzano, diminuiscono a 1500. Quattro anni dopo, nel 1994, chiudono alcuni comparti della chimica: etilene e polimeri. Si abbassano ancora, di conseguenza, i numeri: da tremila a duemila i lavoratori dipendenti, da 1500 a mille i lavoratori dell’indotto. E il declino contagia inevitabilmente l’economia locale.
Dieci anni dopo, nel 2014, chiude la Raffineria tradizionale, i dipendenti dell’Eni sono ridotti a 1280, di cui 800 vengono ricollocati in altri siti in Italia e all’estero e 400 nella raffineria green, sono mille i lavoratori nell’indotto.
Oggi, 2019, si contano 400 dipendenti nella raffineria green, 130 alle dipendenze della Syndial, 600 nell’indotto.
La lenta, inarrestabile, emorragia di posti di lavoro non permette di comparare i guai di Gela con Taranto, che pure ha conosciuto, e conosce, gli stessi problemi vissuti a Gela. Le acciaierie contano diecimila unità ed altrettante in Liguria e Piemonte.
Non credo che i problem solver dell’Eni abbiano seguito una raffinata strategia dei piccoli passi, scandendo con perizia i tempi dell’emorragia ed evitando così un impatto duro con la perdita massiccia di posti di lavoro. Credo piuttosto che le responsabilità maggiori delle Partecipazioni Statali prima e del mix pubblico-privato poi risiedano nell’assenza di una strategia di sviluppo.
Si sapeva come sarebbe andata e non si è fatto nulla perché il territorio, e l’esperimento più importante di industrializzazione del Mezzogiorno, non subisse il collasso, tradendo speranze e illusioni di quanti hanno creduto nella mano pubblica e nelle virtù della grande industria. Coloro che si sono bendati un occhio, talvolta tutti e due, per tenere in vita la fabbrica, nonostante le conseguenze tragiche sull’ambiente e sulla vita delle persone, ora si battono il petto. Se i fumi delle ciminiere tornassero a sporcare il cielo, statene certi, farebbero carte false per affidarsi ancora al carbone. Fino a che il Mezzogiorno può solo buttarsi dalla finestra se non mangia la “sua” minestra, riaccendere le ciminiere è una opzione da non archiviare definitivamente.
L’Eni è rimasta a Gela, mentre i franco-indiani della Mittal ricattano lo Stato minacciando l’abbandono di Taranto. L’Eni a Gela è di casa, il petrolchimico è suo, quindi anche i cocci sono suoi. A Taranto la Mittal è una affittuaria, può lasciare le cose come le ha trovate.
Si era impegnata per contratto a bonificare l’impianto per alleviare le conseguenze dell’inquinamento, e non ha onorato l’impegno. L’Eni, invece, non può andarsene, a meno che non riconsegni Gela come l’ha trovata: campagna, bosco, mare e arenile; tutto come prima, come vuole una legge dello Stato.
La Mittal non rispetta i patti, l’Eni non rispetta una legge dello Stato. Che a sua volta è inadempiente, concedendo a chi deve bonificare un formidabile alibi.