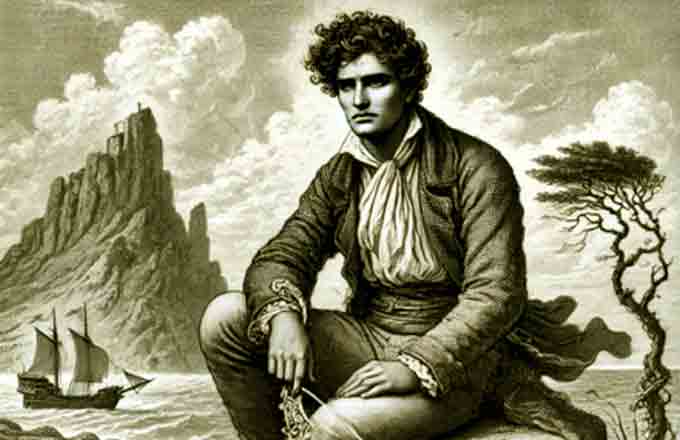IO
Vorrei aprire una finestra sull’attualità cinematografica e televisiva per discutere una questione che mi interessa molto.
Per una curiosa coincidenza, Mediaset ha mandato in onda su Canale 5 un film in due parti su Il conte di Montecristo il 26 e il 27 dicembre scorsi (regia di Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, Francia 2024), mentre Rai 1 ha risposto a stretto giro di posta con una miniserie in quattro puntate doppie mandate in onda di lunedì dal 13 gennaio al 3 febbraio (regia di Bille August, Francia-Italia 2025).
Questo ritorno in grande stile dell’eroe di Dumas (1844-1846) testimonia la sua vitalità e la sua capacità di risorgere ciclicamente con grande successo di pubblico. Vorrei pertanto sollecitarti a discutere tale fenomeno culturale dal punto di vista della teoria dei memi così come è stata declinata da Dawkins, Dennett e Blackmore, considerando cioè la storia come un memeplesso costituito da replicatori minimi (memi) dotati di grande forza virale e capacità di adattamento.
IA
Caro Marco, proverò a fornire un’analisi de Il conte di Montecristo partendo dal punto di vista della memetica e facendo riferimento alle teorie di Richard Dawkins, Daniel Dennett e Susan Blackmore. Considereremo il romanzo di Dumas come un “memeplesso”, ossia un insieme di memi che si replicano e si adattano in base alle dinamiche culturali e comunicative, evidenziando come alcuni elementi narrativi e simbolici possano funzionare da “motore” di diffusione e sopravvivenza di tali memi, rendendo la vicenda di Edmond Dantès uno dei racconti più popolari e “virali” della tradizione letteraria.
Secondo Dawkins (Il gene egoista, 1976), un meme è un’unità di informazione che si trasmette imitando modelli, idee o comportamenti capaci di attecchire nella mente dei singoli, un po’ come i geni si diffondono sul piano biologico. Dennett rafforza questa prospettiva descrivendo i meme come “pensieri che si autopropagano” e dunque competono per l’attenzione, mentre Susan Blackmore, ne La macchina dei memi (1999), mette in luce quanto noi esseri umani siamo predisposti a imitare e a riprodurre continuamente i memi che ci appaiono più rilevanti o affascinanti.
In questo contesto, il successo di un’opera letteraria si spiega con la capacità di offrire memi potenti, emozionalmente coinvolgenti e facilmente adattabili: Il conte di Montecristo risponde perfettamente a questi criteri. Anzitutto, il meme della vendetta, che muove gran parte del romanzo, è di natura fortemente universale, poiché attinge a bisogni emotivi profondi; la drammatica ingiustizia subita da Dantès e il suo desiderio di riscatto parlano a generazioni diverse e si prestano a interpretazioni sempre nuove, rendendo la storia “contagiosa” e capace di diffondersi oltre il contesto originario.
A questa carica emotiva si aggiungono altri memi narrativi di grande presa: il tesoro nascosto dell’isola di Montecristo, che funge da elemento fiabesco e insieme strumento di potere; l’uso di identità multiple (Conte di Montecristo, Lord Wilmore, Sinbad il Marinaio, l’abate Busoni), che introduce il meme della maschera e della metamorfosi sociale; la critica a un sistema corrotto, capace di tradire un innocente e spingerlo all’isolamento; la successiva ribalta del protagonista, che rientra in scena con ricchezze smisurate e un fine calcolato di vendetta.
Questa combinazione di temi riesce a conquistare vari ambienti culturali e a rimanere impressa nella memoria collettiva. La loro forza risiede anche nell’elevata adattabilità: ogni trasposizione (cinema, teatro, fumetto, serie TV) può rielaborare la storia sottolineandone di volta in volta gli aspetti romantici, misteriosi, avventurosi o morali, assicurando una continua “mutazione” del memeplesso e, di conseguenza, la sua rinnovata viralità. I personaggi di Danglars, Fernand e Villefort, come incarnazioni dell’inganno e dell’abuso di potere, fungono da memi negativi, antagonisti emotivamente efficaci e facili da odiare, mentre l’Abate Faria, figura di mentore e depositario di segreti, rappresenta un meme positivo che incarna sapere, sostegno e rivelazione.
Dantès stesso diventa emblema dell’uomo che trasforma dolore e disperazione in uno strumento di dominio, innescando un desiderio di giustizia che tocca nervi scoperti del pubblico di ogni epoca. Il risultato è un racconto che, grazie ai suoi memi principali, si è propagato nella cultura occidentale e oltre, mantenendo alto il livello di interesse per la sua rilevanza emotiva e la sua capacità di far convivere le pulsioni fondamentali di rivalsa, redenzione e punizione. In termini evoluzionistici, si può dunque dire che i memi chiave del romanzo hanno dimostrato nel corso del tempo un’alta fitness culturale, perché continuano a risuonare nelle menti di generazioni differenti, vengono citati, reinterpretati e si riproducono attraverso vie sempre nuove, rimanendo vivi nel nostro immaginario.
Spero che questa lettura memetica ti mostri come Il conte di Montecristo sia un perfetto esempio di memeplesso altamente adattivo, in grado di rigenerarsi e resistere alle trasformazioni storiche grazie alla forza dei suoi temi universali e alle emozioni profonde che sa suscitare.
IO
È interessante vedere come questo memeplesso sia a sua volta il risultato della replicazione e del riadattamento di altri memi. Per esempio (e se ne potrebbero fare decine di altri), quando nel capitolo XXV Dantès viene recuperato sull’isola di Montecristo dagli amici contrabbandieri dopo esser riuscito, due capitoli prima, a farsi lasciare là fingendo un infortunio mentre andava a caccia di capre tra gli scogli (aveva bisogno di rimanere da solo alcuni giorni per trovare il tesoro di Faria), la voce narrante lo paragona ironicamente a un “Filottete ferito”, a sua volta un altro meme culturale virale e resistente attraverso i millenni.
IA
Il richiamo a Filottete – l’eroe greco abbandonato sull’isola di Lemno a causa della ferita che emanava cattivo odore – dimostra con grande chiarezza come Il conte di Montecristo si collochi nel solco di una tradizione millenaria, attingendo a un vasto “serbatoio” memetico già consolidato nella cultura occidentale. Il mito di Filottete, narrato nelle tragedie di Sofocle, ci presenta un eroe fondamentale per la conquista di Troia, lasciato solo in esilio per anni e poi recuperato dagli Achei quando si rivelò indispensabile.
Questa storia, trasmessa attraverso i secoli, è un esempio di meme resistente che racchiude l’idea di un personaggio emarginato ma dotato di una risorsa unica e irrinunciabile, costringendo il contesto che lo aveva escluso a riconsiderare la propria decisione. Dumas utilizza esplicitamente il parallelo con Filottete nel momento in cui Dantès, per restare sull’isola di Montecristo e trovare il tesoro, simula di aver subito un infortunio alla gamba così da farsi lasciare indietro dai contrabbandieri. Il riferimento all’eroe greco non è solo un dettaglio erudito, ma un esempio di come il romanzo attinga a narrazioni mitiche, riadattandole alla sensibilità romantica e al tema della vendetta.
Filottete e Dantès hanno in comune la condizione di isolamento e di separazione dal mondo, anche se per motivi diversi: il primo è afflitto da una piaga autentica, il secondo finge una menomazione per i propri scopi. Entrambi si trovano tagliati fuori dalla vita sociale e trasformano tale esperienza in una prova iniziatica che li rende più consapevoli e preparati quando arriva il momento di tornare in scena.
Nel mito greco, Filottete è cercato dagli Achei perché il suo arco, dono di Eracle, risulta essenziale per la conquista di Troia; nel romanzo, invece, è Edmond Dantès a possedere un “tesoro” in senso letterale, oltre a un piano di vendetta strategica che sconvolgerà la vita di coloro che lo avevano tradito. In questo senso, l’eroe ferito e dimenticato diventa nella storia di Dumas l’uomo ingiustamente incarcerato e poi relegato all’isolamento forzato, il quale rientra nella società con un potere superiore a quello dei suoi ex aguzzini.
L’allusione al mito di Filottete e alla sua dinamica di esilio e ritorno rivela inoltre la capacità della narrazione di legarsi ad archetipi antichi e diffusi, come quello dell’eroe escluso che finisce col rivelarsi determinante per i destini collettivi. Ciò dimostra che Il conte di Montecristo non è solamente un memeplesso a sé stante, ma il risultato di un innesto di memi precedenti che già godevano di ampia diffusione.
L’isolamento eroico, la natura preziosa di un dono (il tesoro di Dantès, l’arco di Filottete), il tradimento del gruppo e la successiva riscossa sono tutti motivi che formano un tessuto memetico resistente al passare del tempo. Chi legge il romanzo può non cogliere immediatamente il riferimento classico, ma percepisce comunque la forza del meme dell’eroe abbandonato che rovescia la situazione.
Questo arricchisce Il conte di Montecristo di una profondità che attinge a una genealogia antichissima: l’opera diventa un punto d’incontro fra il mondo mitologico e la narrativa moderna, adattando un meme già forte (quello di Filottete) in un sistema narrativo romantico che punta sull’individuo e sul suo percorso di ascesa e vendetta. Sotto il profilo memetico, dunque, l’accenno a Filottete ci ricorda come i grandi testi letterari si compongano di elementi culturali eterni, capaci di amalgamarsi e di adattarsi alle esigenze di un pubblico nuovo; questo processo di continua rielaborazione e ibridazione è il segreto di ciò che rende le narrazioni immortali e sempre pronte a suscitare empatia e coinvolgimento emotivo.
IO
Una postilla conclusiva, per chiudere il cerchio. Il meme di Filottete, chiamiamolo così, era replicato nel famoso sceneggiato Rai del 1966 (anche se naturalmente non c’era la menzione esplicita del nome dell’eroe della mitologia greca), mentre non compare nella miniserie del 2025. Esso scompare anche nel film trasmesso da Mediaset alla fine del 2024, così come non compariva nella miniserie trasmessa sempre da Mediaset nel 1998. Lasciamo al lettore una riflessione personale su questo dato grezzo.