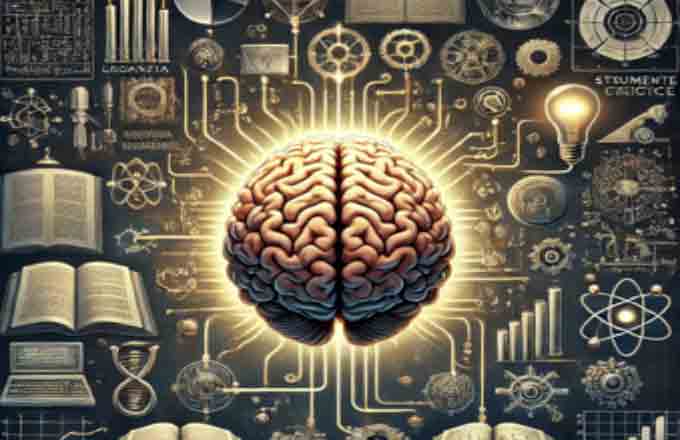In cima ad una piccola catasta di libri che giacciono sulla scrivania in attesa di essere sistemati trovo Canto al deserto di Maria Rosa Cutrufelli, l’unico romanzo ispirato a Mafiaville.
Perché si trovi dov’è, in standby, non so dirvelo. Avrebbe dovuto trovarsi nello scaffale delle opere di autori siciliani. La mia libreria è un labirinto circolare, al quale accedo con sconvolgente semplicità. Vengo messo alla prova qualche volta, non fanno in tempo a pronunciare il nome dell’autore che mi trovo nel posto giusto. Stando così le cose, penso che Canto al deserto volesse essere trovato ed uscire da un ingiusto oblio, durato 29 anni. I libri hanno tante vite, quante i lettori che li leggono, dettando i tempi di vivenza. Forse possiedono altri poteri, di cui non sappiamo niente.
Canto nel deserto sfida i miei sentimenti più reconditi. Non è stato un amore a prima vista, quando lo sfogliai la prima volta. Riprendendolo ora fra le mani, vengo sfiorato da un lieve rammarico, che non è vero e proprio cruccio. Mi era stato richiesto di presentarlo, e come tutto ciò che sa di ingiunzione, imperativo categorico, a prescindere dalle motivazioni, mi ha disposto malamente alla lettura. In questa tagliola corriva sono rimasti intrappolati, dolorosamente, Alessandro Manzoni, Omero e Virgilio. Maria Rosa Cutrufelli è in ottima compagnia, non può lagnarsi più di tanto.
C’è un segnalibro dentro il volume, su cui è scritta a caratteri cubitali una data: 5 novembre 1994, seguita da una indicazione, Chiesetta San Biagio. Alzo gli occhi al cielo, per aiutare la memoria a ricordare, ed è come se si avessi alzato virtualmente un sipario. I pensieri si fanno immagini, la pellicola mostra le sequenze di un episodio vivido nella memoria: sto per accedere nella saletta destinata ad ospitare l’evento, fra siepi ben ordinate, sento un tonfo, mi volto indietro e vedo Maria Rosa Cutrufelli che giace a terra e si copre il viso con le mani. Accanto a lei, Tina, la giovanissima protagonista del suo romanzo, immobile, la faccia tirata, la osserva impassibile. Una piccola folla di divise accorre, sale un brusio indistinto; è lo sconcerto generale, la scrittrice, aiutata ad alzarsi, torna in piedi, e riprendiamo il cammino sul breve sentiero che conduce all’ingresso della Chiesetta sconsacrata.
La liturgia dell’evento prende subito il sopravvento, Canto del deserto cancella tutto, l’uditorio è attento e pacato. E tocca a me parlare. Del libro, che è l’ospite d’onore, non di quanto è accaduto. Subisco la tacita consegna del silenzio senza che alcuno mi avesse sollecitato di tacere. Maria Rosa Cutrufelli è accanto a me al tavolo, l’aggressione non le ha lasciato segni; il viso tradisce certo l’emozione, ma la selvaggia “punizione” è scivolata nel dimenticatoio. Anche lei tace, Tina è una sua creatura, perché farle male? Eppure è di questo, della violenza perpetrata in pubblico, più che una sfida, che avremmo dovuto occuparci; tutto è avvenuto sotto gli occhi di tutti. E’la metafora di Mafiaville nell’anno in cui si suturano ancora le ferite della guerra di mafia, di Gela feroce, infelice, che percorre il suo irreversibile declino, chiusa in se stessa, impietrita, succube.
Canto del deserto racconta la storia di una baby-boss appena quattordicenne, orfana del padre, vittima della guerra di mafia che imperversa a Gela negli anni ottanta. Un colpo di lupara ha segnato la sua vita per sempre. Tina, nome fasullo, è cresciuta nella savana tradimentosa di Mafiaville e non dispone di liane cui appendersi per volare sopra l’intrico della natura aperta e minacciosa: faide, stragi, sicari, trafficanti, colletti bianchi e barbe incolte, e sullo sfondo, come pecore al pascolo, i fantasmi di una città incredula, disorientata, ambigua.
Maria Rosa Cutrufelli protegge Tina, inevitabile vittima; è perciò impietosa, non può non esserlo, verso “l’immenso laboratorio criminale di Gela…, quella tragica città che è all’origine di tutto: una sola grande periferia fatiscente, una popolazione giovane e assolutamente priva di prospettive, il mito mancato dell'industria e l'altrettanto mancato incontro tra due culture (campagna e fabbrica, sud e nord)”. L’identità sofferente della comunità è uno stigma guadagnato sul campo dai piccoli ignari servitori locali del nuovo potere, che ha messo radici nell’arco di un decennio. Gli attori locali devono mandare a memoria il copione scritto dai decision-makers e assistere agli eventi. Non vedono né sentono, ma è come se vedessero e sentissero. Colpevoli senza esserlo?
Agli antipodi c’è Milano, eterna locomotiva d’Italia, con il suo sguardo strabico, interessato. Ha adottato, ignara, verso il Sud l’algoritmo spagnolo della governance, che nel capolavoro di Manzoni regala diritto di cittadinanza ai Bravi di Don Rodrigo e all’Innominato, boss dei boss ai primordi del doppio regime di governo, quello formale e l’altro, parallelo, pietra d’angolo del dominio furbo e cinico. Le regole, ereditate e misconosciute, sono semplici: all’industria quel che gli appartiene, ai cacicchi locali le piccole razzie da distribuire a clientes e mezzani. La rinuncia agli sbandierati effetti moltiplicatori dell’insediamento industriale richiama la cecità interessata che gli sbirri offrono ai confidenti e agli amici in cambio di una concessione, il controllo del territorio. Milano, come Madrid nel Seicento: sono affari loro. Dei siciliani, insomma. Le cose serie si decidono a Milano e a Roma, quel che rimane a Riesi, nel Vallone, e a Palermo, dove i picciotti più lesti fanno presto a costituire il cartello panormita. Nessuno vuole restare fuori dal “progresso”, le commesse dello stabilimento e gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno nelle infrastrutture. Miliardi, tanti miliardi.
Maria Rosa Cutrufelli non abbandona mai la sua capobanda quattordicenne. Ne subisce il fascino maligno, e non solo. Tina la obbliga a trovare la causa della tragedia – la metamorfosi di Gela in Mafiaville – fra le bidonvilles, nella povertà d’animo e di portafogli, nella comunità spaccata fra città e campagna, nord e sud. Non identifica buoni e cattivi, ma è come se lo facesse, perché ognuno porta sulle spalle con il suo zaino colmo l’innocenza colpevole di chi scala una montagna senza indossare arpioni né chiodi.
Stanno davvero così le cose? Non ce lo siamo mai chiesti. Il mondo dei nuovi arrivati, manager, tecnici, cooperatori, è estraneo a Mafiaville? Lo è l’altro mondo, quello degli ex braccianti, pecorai, manovali e proprietari terrieri, apprendisti stregoni e razziatori, capaci di trasformare in business un fazzoletto di terreno paludoso? E’ stata coabitazione da separati in casa quella dei meridionali e della gente del nord? Si sono ignorati o guardati in cagnesco? Il Nord con le sue fisime, i precetti i pregiudizi, l’efficientismo cui obbedire, il tenore di vita da mantenere, la pace sociale da osservare e il Sud, malato di povertà e di solitudine sono incontrati grazie al respiro nuovo del gigante d’acciaio che giace a Piana del Signore, del progresso affannato ma ricco di opportunità, buoni stipendi e salari?
A un quesito complesso ma ineludibile, non so dare una risposta, a differenza di Maria Rosa Cutrufelli, che una risposta ce l’ha, invischiata com’è nella storia di Tina. La chiave sarebbe il matrimonio d’interesse e la distanza di rispetto fra i due ceppi della comunità. Non credo che le cose stiano così, ma non mi sento di sostenere una tesi diversa, perché non possiedo dati e informazioni. Nessuno ha studiato l’immigrazione settentrionale a Gela e l’enclave nord-sud, che rappresenta un caso unico in Italia. Le migrazioni interne non hanno avuto osservatori.
Sia i meridionali gelesi e siciliani, quanto gli immigrati provenienti dal Nord avevano un obiettivo comune, lo sviluppo economico della comunità, terreno fertile per la collaborazione e la solidarietà. Se questa comunanza di interesse non è bastata bisogna chiedersi se siano prevalsi la corruttela, gli intrallazzi, i maneggi. Immaginare che qualcuno a Milano, o dalle nostre parti, si batta il petto è come sperare che la luna, riflessa in fondo al pozzo, armata di buona volontà e fede per il prossimo, esca a rivedere le stelle.