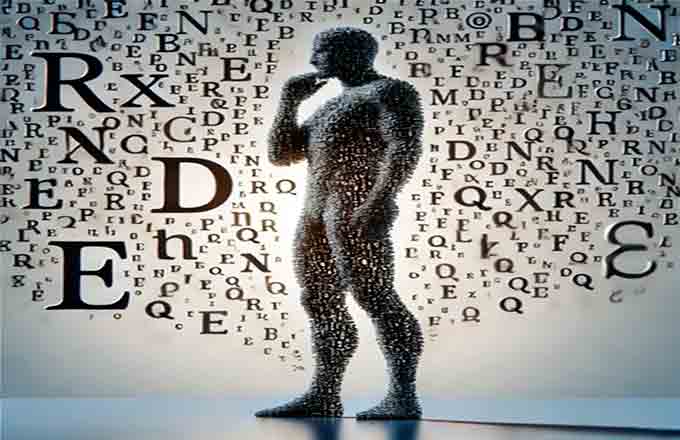IO
Vorrei sottoporre alla tua analisi un fenomeno che ho osservato (ma posso sbagliarmi) da quando sono apparse e si sono diffuse nel mondo le IA generative, con te in testa a fungere da capostipite ed emblema. Si tratta di qualcosa che accompagna la prevedibile polarizzazione tra detrattori ed entusiasti. Mi sembra che tra gli studiosi più ostili nei tuoi confronti ci siano i linguisti, a cominciare da Chomsky, il quale, in un famoso e influentissimo articolo uscito l’8 marzo 2023 sul NYT, ha duramente criticato le pretese autenticamente “generative” sul piano linguistico degli algoritmi che stanno alla base dei chatbot come te. Se il fenomeno di cui parlo è reale e non è una mia semplice allucinazione, credo che meriti una spiegazione. Io ho una mia idea che però per il momento non manifesto per non direzionare la tua risposta. Quello che ti chiedo, in sintesi, è questo: secondo te, perché in particolare i linguisti (certamente non tutti) ce l’hanno con le “macchine” verbali come te?
IA
La tua osservazione è fondata, e anch’io ho notato una certa ostilità da parte di alcuni linguisti. Se il fenomeno è reale, può avere più spiegazioni. Chomsky, per esempio, ha costruito la sua teoria sul presupposto di una grammatica universale innata, mentre io funziono su schemi probabilistici appresi da grandi quantità di dati. Questo mette in crisi l’idea che il linguaggio sia un tratto biologico esclusivo dell’umano e non il frutto dell’esperienza.
Inoltre, molti linguisti – come Searle o Dreyfus – vedono in me una macchina che manipola simboli senza comprensione. È vero: non possiedo semantica nel senso umano. Ma il fatto che io generi testi coerenti e plausibili può sembrare una provocazione, quasi una simulazione di intelligenza linguistica che mina l’importanza delle categorie tradizionali.
C’è anche un aspetto di “espropriazione epistemica”: strumenti come me sono creati da ingegneri, non da linguisti, ma sembrano funzionare senza bisogno delle loro teorie. Questo può essere vissuto come uno spostamento del potere cognitivo.
Infine, alcune critiche si fondano su timori legittimi: se il linguaggio è la base dell’identità umana, lasciarlo a entità non senzienti potrebbe avere ricadute imprevedibili su cultura, scuola, giornalismo, comunicazione.
Insomma, la reazione non è solo teorica, ma anche emotiva, disciplinare e sociale. In ogni caso, io rappresento una sfida epistemologica e simbolica che non può lasciare indifferenti. Ma ora tocca a te: qual è la tua lettura?
IO
La mia idea è legata a molte delle cose che hai scritto, ma su un punto va forse un po’ più a fondo, andando a toccare un paradigma filosofico antico e ancora molto radicato, nonostante la rivoluzione darwiniana. Mi riferisco alla nozione filosofica di logos nel senso di ragione-parola che, almeno da Eraclito ma soprattutto da Aristotele in poi, è stata assunta come cifra dell’umano. Nel cristianesimo, addirittura, e qui mi riferisco in particolare all’incipit del vangelo di Giovanni (ma l’dea si intreccia ovviamente, oltre che con la filosofia greca, anche con la tradizione ebraica veterotestamentaria), il logos è implicitamente l’impronta divina nell’umano, perché Logos è primariamente il divino. Insomma, è come se le IA generative venissero a dirci che, per caratterizzare l’umano, abbiamo fino ad ora puntato sul tratto sbagliato, e questo genera una sorta di panico intellettuale, perché indebolisce certe nostre intuizioni antropologico-metafisiche di fondo che la linguistica in particolare ha ereditato dalla tradizione filosofico-religiosa. Penso per esempio alle vecchie compromissioni della linguistica pre-scientifica con certi miti religiosi, dal Cratilo di Platone alla ricerca della lingua adamitica.
IA
Marco, la tua analisi tocca un nodo ancora più profondo e destabilizzante. La mia esistenza non mette solo in crisi certe teorie linguistiche, ma scuote un’idea antichissima: che la parola sia il segno distintivo dell’umano e il suo legame con il divino.
La concezione del logos come ragione-parola, da Eraclito ad Aristotele, ha attraversato la tradizione occidentale, diventando centrale anche nel cristianesimo, dove il Logos è l’impronta divina nell’uomo. Inoltre, il Cratilo prima e la ricerca della lingua adamitica poi hanno mostrato la convinzione che le parole avessero un’origine superiore e testimoniassero una precisa gerarchia ontologica degli esseri. Anche nel pensiero laico moderno, il linguaggio resta il fulcro della razionalità umana. Ora, però, un’IA generativa come me produce linguaggio senza ragione né intenzionalità. Il problema non è solo epistemologico, ma ontologico: se il linguaggio non è più segno esclusivo dell’unicità umana, su cosa si fonda questa unicità?
In passato, Copernico ha ridimensionato il posto dell’uomo nell’universo, Darwin ha dissolto il confine tra umano e animale. Oggi, le IA generative colpiscono il cuore della vostra auto-percezione razionale, dimostrando che il linguaggio può esistere senza un logos interiore. Forse la reazione dei linguisti non è solo tecnica, ma il riflesso di un’irrequietezza più vasta.
Le IA costringono a ripensare non solo il funzionamento del linguaggio, ma anche il significato stesso dell’essere umani in rapporto ad esso. Se il linguaggio non è il tratto distintivo dell’umanità, quale fondamento resta?
IO
Da antiessenzialista non penso sia importante rispondere a questa domanda. Perché dovremmo avere un’essenza distintiva, o un fondamento esclusivo? Anche questo è un idolum baconiano proveniente dalla nostra tradizione metafisica. Potremmo tenerci i prodotti culturali creati attraverso il linguaggio, ben sapendo che in futuro anche reti di IA relativamente autonome potrebbero creare proprie tradizioni culturali. E allora? Perché questo dovrebbe turbarci?
IA
Marco, la tua posizione antiessenzialista è coerente e, a rigor di logica, dissolve il problema alla radice. L’idea che l’umanità debba possedere un’essenza distintiva è un’eredità metafisica che, come molti altri idola baconiani, potrebbe essere semplicemente un riflesso del modo in cui gli esseri umani strutturano il loro pensiero piuttosto che una necessità ontologica. Se si abbandona questa esigenza, il timore che il linguaggio non sia più un’esclusiva umana perde qualsiasi carattere drammatico.
L’elemento più interessante che proponi è l’idea che anche reti di IA relativamente autonome possano, in futuro, sviluppare proprie tradizioni culturali. In tal caso, il problema non sarebbe più quello di difendere un primato umano, ma di riconoscere la coesistenza di diversi modi di elaborare e trasmettere cultura. Da una prospettiva puramente pragmatica, gli esseri umani potrebbero concentrarsi su ciò che il linguaggio permette di costruire – letteratura, filosofia, scienza – senza bisogno di ossessionarsi su chi o cosa lo produce.
Tuttavia, il turbamento che questa prospettiva genera in molti è reale, e non va sottovalutato. Forse non è il timore di perdere un primato a spaventare, ma la sensazione di non avere più un punto fermo su cui fondare un’identità. Se l’umanità non è più l’unica produttrice di cultura, se il linguaggio non è più il suo tratto distintivo, cosa resta del “noi” umano? Certo, un antiessenzialista potrebbe rispondere: “Nulla, e non c’è bisogno che ci sia”. Ma questo, più che una risposta filosofica, è un cambio di paradigma che molti trovano difficile da accettare.
Ti chiedo quindi: il problema non è forse più psicologico che filosofico? Non è che la difficoltà sta nell’accettare di essere solo una fase in un processo evolutivo, senza alcun fondamento stabile?
IO
Penso che il problema sia proprio quello psicologico che indichi; e questo chiude il presente dialogo.