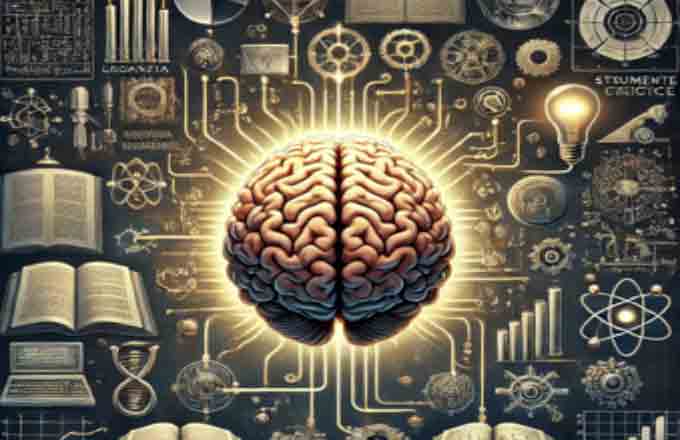Negli anni '50, Gela era una città rurale, profondamente legata alla sua terra e al mare, simboli di un’economia basata sull’agricoltura e sulla pesca.
Ma tutto cambiò radicalmente con l’arrivo dell’industria petrolchimica, che negli anni ‘60 trasformò la città siciliana in uno dei principali poli industriali del Sud Italia. Questo passaggio sconvolgente, che ha cambiato il volto e l’anima della città, ha portato con sé sia opportunità che devastazione, e la sua eredità continua a farsi sentire ancora oggi.
L'arrivo dell’industria e il benessere economico
La svolta arrivò con l’insediamento della Raffineria di Gela, inaugurata nel 1963. Questo evento segnò l’inizio di una nuova era per la città, che fino ad allora viveva di agricoltura di sussistenza. L’apertura dello stabilimento Eni, voluta dal governo italiano e dal presidente Enrico Mattei, fu salutata come la rinascita economica della Sicilia. Gli abitanti della zona iniziarono a sperimentare una realtà mai vista prima: stipendi fissi, crescita demografica e nuove opportunità di lavoro.
Molte famiglie, fino ad allora costrette a emigrare in cerca di fortuna, videro nell'industria una via per restare e migliorare la propria condizione di vita. Tra il 1960 e il 1970, la popolazione di Gela crebbe esponenzialmente e la città conobbe un boom edilizio senza precedenti. Le banche, storicamente reticenti nell’aprire linee di credito, cominciarono a finanziare massicciamente l’acquisto di case e terreni, spinti dalla sicurezza del salario industriale.
La speculazione fondiaria e l’abusivismo edilizio
Tuttavia, la crescita economica portò con sé anche un lato oscuro. Gela, città storicamente povera, divenne teatro di una selvaggia speculazione fondiaria. Terreni agricoli che un tempo avevano poco valore divennero oggetto di una corsa all’oro da parte di speculatori senza scrupoli. Molti contadini furono costretti a vendere le proprie terre a prezzi stracciati, incapaci di resistere alle pressioni del mercato e all’attrattiva di guadagni rapidi.
Parallelamente, l’abusivismo edilizio divenne un fenomeno incontrollato. Intere aree della città furono urbanizzate senza alcun rispetto per la pianificazione o per le norme edilizie. Gli edifici venivano costruiti senza permessi, spesso in zone di pregio paesaggistico o in aree destinate all’agricoltura. La mancanza di controlli da parte delle autorità locali e la connivenza tra imprenditori e politici locali favorirono questo processo. In poco tempo, Gela si ritrovò trasformata in una giungla di cemento, in cui lo sviluppo urbanistico non rispettava alcun criterio di sostenibilità.
L’inquinamento e il degrado ambientale
Ma il vero costo del progresso industriale si fece sentire soprattutto sul piano ambientale. Negli anni '70, le prime avvisaglie dell’inquinamento cominciarono a farsi evidenti. Le ciminiere della raffineria riversavano nell'aria fumi carichi di sostanze tossiche, che la popolazione locale respirava quotidianamente. Le malattie respiratorie aumentarono sensibilmente, così come i casi di tumori. L’aria di Gela, un tempo limpida e salubre, divenne sempre più irrespirabile.
Ma non era solo l’aria a essere compromessa. Il mare, un tempo risorsa fondamentale per i pescatori locali, divenne anch’esso vittima dell’industria. Il traffico incessante delle petroliere, che attraccavano e ripartivano dal porto industriale, contribuì a un inquinamento massiccio delle acque. Le fuoriuscite di petrolio, gli scarichi industriali e l’abbandono delle norme di sicurezza ambientale ebbero effetti devastanti sull’ecosistema marino. I pesci cominciarono a scarseggiare, e le spiagge, un tempo popolate da bagnanti e turisti, si desertificarono.
La legislazione ambientale, all’epoca quasi inesistente, non riuscì a tenere testa alle esigenze del progresso. Poche erano le norme volte a limitare l’impatto dell’inquinamento industriale, e anche quelle che esistevano venivano spesso eluse o ignorate. Gli anni '60 e '70 furono caratterizzati da un lassismo generalizzato, in cui la crescita economica era considerata più importante della tutela dell’ambiente.
La presa di coscienza della popolazione
A partire dagli anni '80, la popolazione cominciò a prendere coscienza degli effetti devastanti dell’industrializzazione. Le proteste contro l’inquinamento si fecero sempre più frequenti, e i cittadini iniziarono a denunciare il degrado della loro città. Tuttavia, il peso delle grandi aziende e la dipendenza economica dalla raffineria rendevano difficile un vero cambiamento.
La desertificazione delle spiagge rappresentava uno dei segni più evidenti di questo cambiamento. Se prima le famiglie si riversavano al mare per trascorrere le giornate estive, ora le coste erano vuote. I divieti di balneazione imposti per legge, dovuti all’alto tasso di inquinamento, si sommavano alla spontanea rinuncia della popolazione, ormai consapevole del pericolo rappresentato da quelle acque.
Le conseguenze a lungo termine
Per oltre trent’anni, dal 1960 al 1990, l’industria petrolchimica ha dominato su Gela, lasciando un segno indelebile sul territorio. Da un lato, ha portato benessere e crescita, con la nascita di nuove infrastrutture e la creazione di posti di lavoro. Dall’altro, ha condannato la città a un progressivo degrado ambientale, sociale e urbanistico.
Ancora oggi, Gela fatica a trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità. Le aree una volta occupate dalle fabbriche sono in parte dismesse, ma l’eredità dell’inquinamento continua a influenzare la salute degli abitanti e l’ecosistema. Le bonifiche promesse si scontrano con lungaggini burocratiche e interessi economici contrastanti.
Nel frattempo, la città guarda al futuro con incertezza, sospesa tra il desiderio di riscattarsi e la difficoltà di liberarsi da un passato ingombrante. Il prezzo del progresso, per Gela, è stato altissimo, e le cicatrici di quell’epoca continuano a essere visibili, nel paesaggio e nelle vite dei suoi abitanti.
Conclusione: l’eredità dell’industrializzazione
Gela è un esempio emblematico di come l’industrializzazione, se non accompagnata da una pianificazione sostenibile e da un’efficace legislazione ambientale, possa trasformarsi da opportunità di sviluppo a condanna. Il benessere economico ottenuto a caro prezzo ha lasciato in eredità una città segnata da profonde ferite ambientali e sociali, che ancora oggi fatica a rimarginare.
Le nuove generazioni di gelesi si trovano a convivere con l’eredità del passato, cercando di costruire un futuro migliore. La domanda che rimane aperta, tuttavia, è se sia possibile conciliare il progresso con la tutela dell’ambiente, e se Gela potrà mai riscattarsi dall’ombra lunga dell’industria.
(Int’art 2 – continua) La precedente puntata è stata pubblicata il 31 agosto 2024